"Viviamo in un'epoca di potere sfrenato e forza bruta": Andrea Rizzi

Viviamo in un'epoca segnata dalla brutalità, un nuovo ordine mondiale in cui due blocchi contrapposti sono guidati da una spinta comune: la riparazione. Nel suo saggio L'età della vendetta (Anagrama), Andrea Rizzi (Roma, 1975) analizza questi tempi, ricchi di demagoghi e dittatori che fomentano nazionalismo e divisioni politiche.
Giornalista, Rizzi lavora come corrispondente per gli Affari Globali del quotidiano spagnolo El País, dove pubblica una rubrica di opinione dedicata all'Europa. Per l'analista, che interverrà all'Hay Festival di Segovia a settembre, il mondo oggi presenta due blocchi. Da un lato, l'Oriente, dove Russia e Cina, tra gli altri paesi, cercano di recuperare e rivendicare un passato "glorioso" di cui si sentono ingiustamente private; e dall'altro, l'Occidente, con le sue classi lavoratrici che si sentono emarginate mentre assistono alla crescente ricchezza delle classi superiori in democrazie inefficaci. In entrambi i casi, prosperano la disinformazione e le politiche identitarie ed emotive.
«L’era della vendetta è il tempo della grande ipnosi, in cui i regimi autoritari e populisti inducono metodicamente nella popolazione un crescente stato di sonnolenza del discernimento», sostiene Rizzi. In un'intervista con questo giornale, "Menzogne e suggestioni coprono i fatti. E lo fanno con una capillarità mai vista prima, grazie ai progressi tecnologici".
Lo stile di Rizzi non è solo quello di un lucido analista internazionale, ma egli costruisce le sue argomentazioni su una profonda conoscenza della letteratura, che usa per comprendere la miseria e la virtù umana, nonché per approfondire i concetti di libertà e potere.
Una delle rivincite che il tuo libro evidenzia è quella dell'Oriente: Russia e Cina cercano di imporsi sulla potenza occidentale. Sono davvero così unite? Non si tratta di un'alleanza formale. Non hanno un trattato che stabilisca, ad esempio, una clausola di mutua difesa. E ci sono dei limiti al loro rapporto, anche se hanno dichiarato pubblicamente di avere un'amicizia sconfinata. Ma questo non dovrebbe indurci a sottovalutare l'importanza del loro legame. C'è un episodio chiave. Un incontro dei loro leader tenutosi nel marzo 2023 in cui hanno fatto una dichiarazione congiunta fondamentale: hanno compreso che la democrazia e i diritti umani non sono valori universali, ma che ogni nazione ha il diritto di combinarli secondo la propria tradizione.
Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per chiunque creda nella democrazia e nei diritti umani. Quel giorno, Xi Jinping disse a Putin: "Stiamo assistendo a cambiamenti mai visti negli ultimi 100 anni. E quando restiamo uniti, li guidiamo".
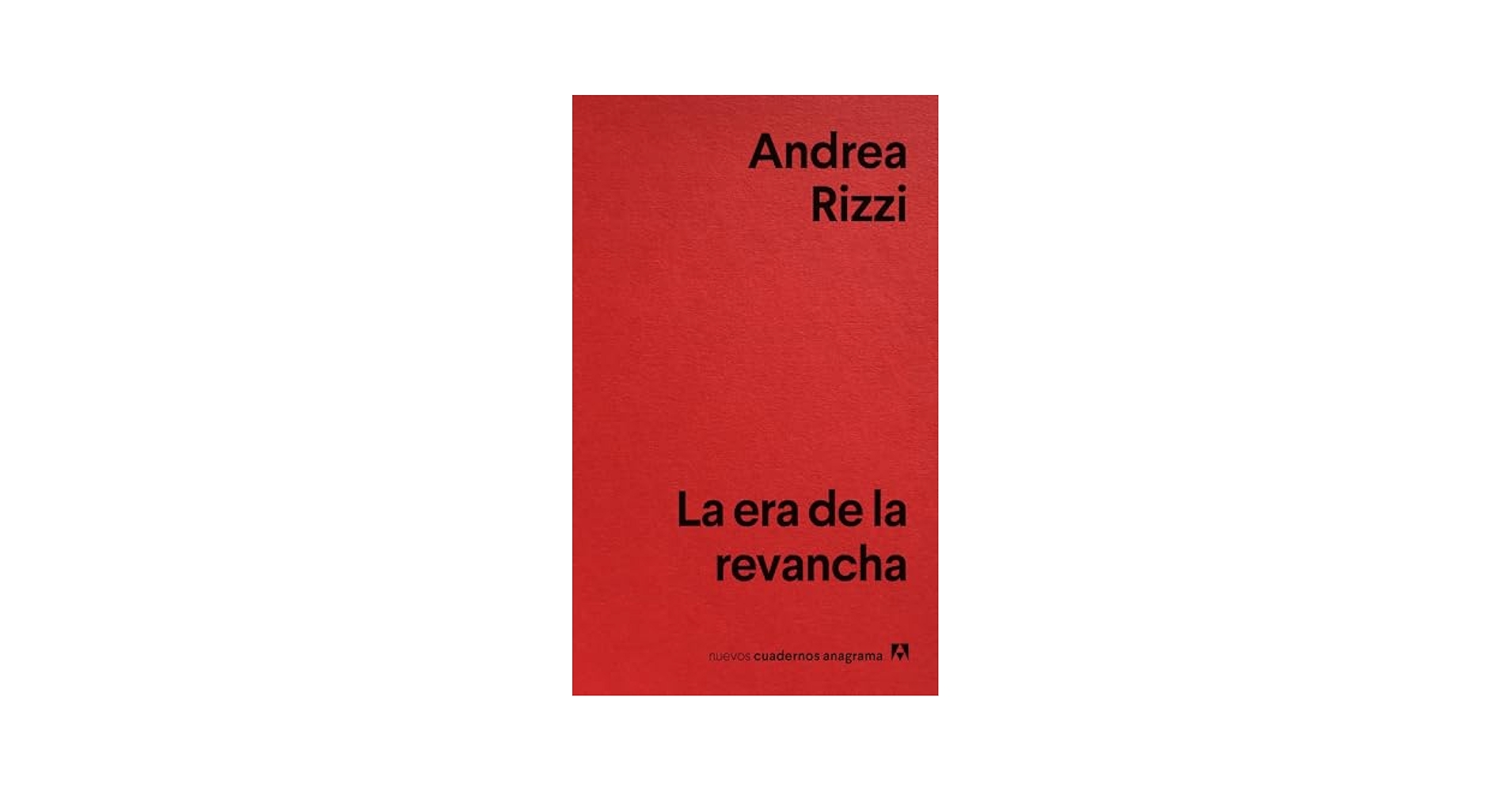
'L'età della vendetta', un libro di Andrea Rizzi, pubblicato nel gennaio 2025. Foto: Casa editrice Anagrama.
L'ascesa delle forze nazionaliste e populiste è dovuta in gran parte a un malcontento sociale che ha alimentato il risentimento tra ampi strati della classe operaia e che i populisti hanno abilmente sfruttato. Prima, ascoltandolo, poi spronandolo e cavalcandolo. L'alternativa a queste forze deve comprendere appieno le cause di questo malcontento. E queste sono molteplici: credo che alcuni degli eccessi del capitalismo degli ultimi decenni abbiano contribuito a questo malcontento, i problemi della globalizzazione, della rivoluzione tecnologica e un certo grado di inefficacia nelle democrazie che, in alcuni casi, ha raggiunto quasi la paralisi.
È necessario proporre una sfida radicale al modello precedente. È importante preservare la coesione sociale, perché negli ultimi decenni si è verificata un'asimmetria, per cui le classi superiori hanno tratto vantaggio da questo mondo globalizzato nel mezzo di una rivoluzione tecnologica. E molte classi lavoratrici non sono state in grado di mantenere o difendere la propria posizione e hanno perso posti di lavoro stabili nel settore manifatturiero, diventando precarie. Si è creata una frattura sociale che ha generato risentimento. Voglio sottolineare un elemento fondamentale: l'attenzione ai sistemi educativi. Sono fondamentali per garantire che ogni cittadino abbia spirito critico e capacità di discernimento per orientarsi nel mondo moderno e capire dove si verificano manipolazioni delle menti o fake news.
È importante prendersi cura della coesione sociale, perché negli ultimi decenni si è verificata un'asimmetria grazie alla quale le classi più abbienti sono riuscite a trarre vantaggio da questo mondo globalizzato nel mezzo di una rivoluzione tecnologica.
Sì, l'Occidente ha favorito la straordinaria crescita economica della Cina, includendola nel sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e trascurando alcuni aspetti di questa nuova relazione. Ciò ha prodotto effetti collaterali dannosi per le economie industrializzate occidentali. L'ingresso della Cina nell'OMC ha permesso un progresso economico probabilmente senza precedenti nella storia dell'umanità. E questo è positivo. Ha fatto uscire centinaia di milioni di persone dalla povertà in Cina e ha permesso ai consumatori del resto del mondo di accedere a prodotti a basso costo, contenendo così l'inflazione. Tutto ciò è positivo. Tuttavia, alcuni effetti collaterali sono stati trascurati, come i trasferimenti forzati di proprietà intellettuale applicati alle aziende del resto del mondo che volevano affermarsi nel mercato cinese.
La vendetta implica odio. Lo vediamo nel discorso politico. Ma c'è anche una grande polarizzazione tra i cittadini. Questi scenari sono stati creati dal populismo o ne sono una conseguenza? Viviamo in un'epoca di polarizzazione esacerbata. Questo fenomeno si riproduce quasi ovunque nelle democrazie del mondo. Credo che i problemi materiali che hanno generato disordini non siano di per sé la causa della polarizzazione. C'è un fattore essenziale nel generare la polarizzazione, ed è l'azione consapevole e deliberata di alcuni attori. Giuliano da Empoli li chiama gli "ingegneri del caos": sono la chiave per comprendere la polarizzazione e hanno saputo esplorare i disordini. Ma poi li hanno usati per consolidare i loro interessi politici.

Rizzi è corrispondente di affari internazionali per il quotidiano spagnolo El País. Foto: tratta da X @and_rizzi
Si tratta di un gruppo di figure con una vasta conoscenza del mondo digitale, una profonda comprensione delle dinamiche del marketing politico e che hanno costruito relazioni con leader populisti.
Elon Musk? Sì, certo, e Donald Trump e Steve Bannon. Ci sono Cambridge Analytica e la Brexit. Ci sono Gianroberto Casaleggio e il Movimento Cinque Stelle in Italia, per citare un esempio che non è ultranazionalista, perché gli "ingegneri del caos" non sono solo ultranazionalisti. Sono colpevoli di un terribile deterioramento del tessuto sociopolitico, al punto che le nostre società non hanno quasi più ponti. Farli saltare in aria è stato molto facile; ricostruirli sarà molto difficile.
Il presidente Javier Milei riuscirà a collocare l'Argentina in una posizione di rilievo sulla mappa geopolitica? Oggi, le regole e le istituzioni internazionali sono sempre meno rispettate e la forza bruta conta sempre di più. In questo nuovo mondo, quindi, coloro che avranno un ruolo di primo piano geopolitico saranno i paesi che esercitano la forza bruta. È davvero triste. Viviamo in un'epoca di poteri scatenati, con, in alcuni casi, istinti imperialisti. Abbiamo appena partecipato a un vertice NATO in cui gli alleati europei, ad eccezione della Spagna, si sono impegnati a un aumento straordinario della spesa militare. Ciò che conta oggi è la forza bruta e la forza strategica, ovvero la potenza tecnologica e innovativa. In questo mondo, paesi come l'Argentina, ma anche molti altri, come la Spagna, sono esclusi dal ruolo di primo piano geopolitico.
Oggigiorno le regole e le istituzioni internazionali sono sempre meno rispettate e la forza bruta è sempre più importante.
Non è facile essere ottimisti. Ma questo non significa abbandonarsi al disfattismo. Credo che l'Unione Europea continuerà a esistere. Al suo interno c'è una forte consapevolezza di questo cambiamento epocale. E che questo cambiamento epocale richieda un profondo adattamento del progetto europeo comune, in termini di maggiore integrazione, per evitare di essere travolti da questo nuovo mondo di tendenze imperialiste, con potenze scatenate in difesa dei propri interessi. Ciò ha a che fare sia con la forza dei partiti nazional-populisti all'interno del progetto europeo, che ovviamente ostacolano tale integrazione, sia con forze nominalmente filoeuropee aggrappate a meschini interessi nazionali. Abbiamo, da un lato, il mostro nazionalista e, dall'altro, l'interesse nazionale miope.
La Spagna è immersa in una crisi politica, con malcontento dei cittadini e scandali di corruzione. Qual è la soluzione a questa crisi che colpisce il governo, incapace di raggiungere un consenso su leggi essenziali, come la legge di bilancio? La Spagna si trova ad affrontare una situazione dicotomica. Ha un'economia dinamica che crea posti di lavoro e una comunità fiorente. Tuttavia, il settore politico sta attraversando una profonda crisi. Se la domanda è come immagino la via d'uscita, si può naturalmente riflettere sugli elementi più immediati che potrebbero innescare una soluzione: un voto di fiducia, l'indizione di nuove elezioni, la proposta di un voto di sfiducia. Ci sono diverse strade. Per il momento, credo che il governo spagnolo sia determinato a rimanere al potere, anche se la sua capacità di azione è fortemente limitata. Pertanto, ritengo improbabile che uno qualsiasi di questi scenari si verifichi a breve termine. Vorrei però offrire quella che ritengo una risposta più profonda riguardo alla soluzione. La Spagna deve uscire da questa spirale di polarizzazione velenosa in cui si trova e in cui sta sprofondando. Una spirale governata da un senso di irrazionale faziosità. Prevale il sentimento di "serramento dei ranghi", persino al di sopra dei valori. Ci sono elementi, soprattutto nella parte destra dello spettro politico, che hanno alimentato questa polarizzazione, generando un effetto contrario che ha generato a sua volta una polarizzazione dall'altra parte. Ciò rende impossibile trovare soluzioni razionali ai problemi politici. Pertanto, per me, la vera soluzione, oltre a quella immediata, è la ribellione.
Una ribellione? Come? Come quella a cui siamo chiamati, da fonti molto diverse, da Albert Camus ne "L'uomo in rivolta" o da Italo Calvino ne "Il barone rampante". Il protagonista di questo romanzo, a dodici anni, si ribella ai suoi genitori, che sono dell'Ancien Régime, rappresentanti di una politica irrazionale. Vogliono dargli da mangiare lumache per pranzo. Lui dice loro: "No, no e no". Si arrampica fuori dalla finestra e si nasconde tra gli alberi. Ebbene, dobbiamo dire "no, no e no" a quella politica. E generarne una che non sia polarizzata ed emotiva, ma razionale. Ci sono elementi della difesa della democrazia che ora sono essenziali. Dobbiamo superare la polarizzazione emotiva per reindirizzare questo Paese verso una politica più sana e costruttiva.
Nel tuo saggio, sostieni che i social media e l'intelligenza artificiale siano strumenti di sorveglianza che hanno minato la democrazia. In che modo? I social media ci spiano, lo sappiamo, non siamo ingenui. Possiamo e dobbiamo avere una responsabilità civica nei confronti dei social media. L'intelligenza artificiale è, ovviamente, una realtà multiforme che porterà grandi benefici agli esseri umani. Allo stesso tempo, comporta enormi rischi, come quelli socioeconomici, nel senso che può sconvolgere i mercati del lavoro, contribuendo forse a fomentare le disuguaglianze. I social media possono svolgere un ruolo particolarmente dannoso perché viviamo in un'epoca di guerra cognitiva globale, una lotta per la mente delle persone. A questi fattori si aggiunge l'enorme potenziale dirompente dell'intelligenza artificiale, che può creare contenuti che migliorano la capacità di ipnosi delle persone. Quindi dobbiamo esserne consapevoli e cercare di reagire.
Come si potrebbe esercitare la responsabilità civica? Questo deve provenire dalle autorità pubbliche, ad esempio attraverso azioni di regolamentazione. L'Unione Europea ha già intrapreso iniziative in questa direzione con normative pionieristiche sull'intelligenza artificiale, così come sui servizi digitali. Il ruolo dei media è fondamentale, si spera, nell'offrire narrazioni sane che contribuiscano ad aiutare i cittadini a formulare giudizi equilibrati sulle cose. Tuttavia, credo che non dobbiamo cadere nel paternalismo: anche i cittadini hanno le loro responsabilità. Il poeta italiano Eugenio Montale ci ha incoraggiato con versi che, a mio avviso, sono straordinariamente attuali: "Cerca una maglia rotta nella rete / che ci opprime, salta fuori, fuggi!"
Per la Nazione (Argentina) – GDA
eltiempo

%3Aformat(jpg)%3Aquality(99)%3Awatermark(f.elconfidencial.com%2Ffile%2Fbae%2Feea%2Ffde%2Fbaeeeafde1b3229287b0c008f7602058.png%2C0%2C275%2C1)%2Ff.elconfidencial.com%2Foriginal%2F02b%2F16c%2F51d%2F02b16c51d6577db09a115c29c77b1d62.jpg&w=1280&q=100)


